Cercavamo l’uomo nuovo. Ancora uno, l’imprimatur è una specie di maledizione, i destinatari finiscono per riparare in un qualche recinto di confine: l’infamia, una sconfessione tout court, o la sollevazione del consiglio comunale. L’uomo nuovo di Messina per tutti era il sindaco scalzo, quello delle magliette pacifiste con la scritta Free Tibet, Renato Accorinti, il potestà buddista, il neofita innocente – su cui si è interrogato con una certa curiosità Der Spiegel – dogma usato fino a sfiorare la retorica di un badge, non politico per definizione. Oggi il manifesto virtuoso è la taglia sulla sua testa. L’uomo della rivoluzione. Solo che a Messina le rivoluzioni devono durare poco. In Sicilia, in generale. Avevamo creduto ai Forconi, alla veemenza di Mariano Ferro, per doverci ricredere quasi vergognosamente, restando nella medesima impasse: restando i soliti “cornuti” dello Stivale. Spariscono gli impeti, salvo sommosse da outlet, approntate e maldestre. Accorinti prometteva la sua rivoluzione dal basso, intestandosi l’omonima lista civica. In consiglio adesso vogliono votarne la sfiducia, evitare il commissariamento, toglierselo di mezzo. Lo stanno facendo, persino i suoi, simpatizzanti della rivoluzione della prima brevissima ora.

Messina
Messina fondamentalmente rimane di destra, malgrado sia ancora in forza un pd filaccioso, dove non smettono di addensarsi ombre da prima repubblica. La genealogia riconduce tutti a casa, il vecchio sistema da rodaggio consolatorio, il sistema da obsoleta Dc, con i suoi nipoti e pronipoti. O se vogliamo il cosiddetto “sistema Genovese”. Come lo chiamano in città. Cioè o stai dentro o stai fuori. Accorinti sta abbastanza fuori, da buon cane sciolto. Nel corso principale incontriamo nostalgici e reazionari, non di Accorinti, ma di chi pare – almeno nella convinzione dei messinesi – conti sul serio, faccia girare potere, economia, dunque Francantonio Genovese. Lui non era certo l’uomo nuovo, sindaco, onorevole, nipote del ministro Gullotti. Era l’uomo della formazione professionale, però. Finita quella, con buona pace di Crocetta, finisce tutto. Al bar di viale San Martino, al tavolo, discutono alcuni veterani della formazione. Disoccupati che hanno superato i quarant’anni, come Salvatore Romeo o Saverio Arnone che di anni ne ha 58, potevano aspettare e andava in pensione. Invece lui, l’amico e altri ottomila oggi mantengono la loro medaglia di fuoriusciti. “E’ crollato un regno” – dice Saverio Arnone, lui non ha votato Accorinti comunque. Lo ha votato l’amico Salvatore, nostalgico di una promessa: la rivoluzione. Niente da fare. “I messinesi – dice – vogliono i padroni di prima”. Lasciando intendere che non se ne sono mai andati. Come se fosse possibile. “Messina vuole i cambiamenti, con Accorinti non ci sono stati”. Subito? Una rivoluzione siciliana ha bisogno di secoli, a esser precisi. E’ solo un altro modo per ammazzare il tempo, fintanto le cose procedano con il medesimo metodo. Stai dentro o stai fuori. Accorinti non è furbo abbastanza. E’ questa è un’opinione diffusa. Mischinu, quasi “babbu”. Babbu per i siciliani è un modo per indicare una certa estenuante purezza, una poca praticità. Gli uomini seduti al bar convengono sulla sventura di una tale purezza. Uno di loro azzarda: non ha nemmeno gli uomini giusti. Accorinti è solo. Ma è la storia siciliana, noiosa, rincorre identiche tipologie di superuomini: uomini normali affetti da una discreta confidenza con la legge, con la legalità. Superuomini o negletti sconfessati nel civico consesso. Uomini giusti Accorinti non ne ha azzeccato uno o forse sì, l’assessore al bilancio, il toscano Luca Eller, e anche il direttore generale dell’azienda municipalizzata dei trasporti (Giovanni Foti, nda) che è torinese e che ha messo a posto almeno una rubrica. Corpi estranei, il vino buono nella otre vecchia. L’esterofilia ha funzionato per rimettere a posto qualcosa. Con Eller il rischio default viene scongiurato. Una mostrina al petto per Accorinti. Gli autobus coprono le tratte senza singhiozzo. Potrebbe bastare, per cominciare. No. Il sindaco indossa la maglietta con su scritto: Free Tibet. A Maggio ha invitato il Dalai Lama. Messina ha una vocazione conservatrice. Vuole vedere gli obiettivi, la marcia pratica del reazionario in grado di misurarsi fino a vincere nel ballottaggio con un uomo di Genovese, ancora lui, tal Felice Calabrò. Arrivò a Palazzo Zanca a piedi nudi. Una trovata strampalata per annunciare uno stile. A piedi nudi, diceva Accorinti, “per restare con i piedi per terra”. Messina si trova spaccata: nostalgici e reazionari. I reazionari non sono necessariamente anime belle, sono i non ricollocati, i ricollocati non del tutto, coloro che se non hanno potuto con Genovese, ci riprovano con Accorinti. Accorinti che era partito con il distintivo “No Ponte” ed è finito con un Free Tibet accolto con disdegno dai suoi elettori, alla fine della fiera e non proprio del mandato. Perché in definitiva cercavamo l’uomo nuovo soltanto per trovare la medesima storia siciliana. E’ una vecchia storia. Non ne usciremo mai.
L’originale è uscito il 29 gennaio 2017 sulle pagine de Il Fatto Quotidiano (“Messina, la svolta azzoppata e il “richiamo” dei padroni”)
potete leggerlo anche qui: http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/messina-la-svolta-azzoppata-e-il-richiamo-dei-padroni/


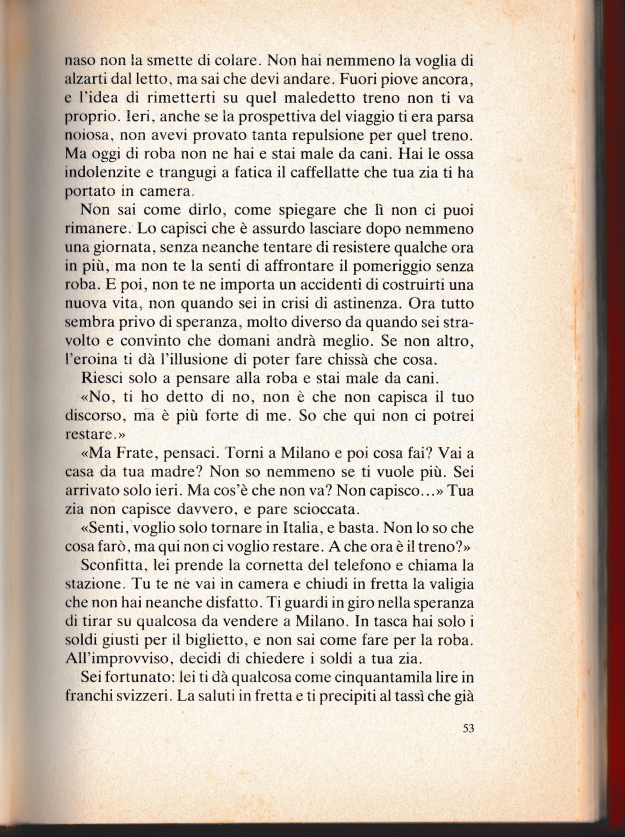



You must be logged in to post a comment.