Gentile Veronica Tomassini,
Abbiamo letto il suo articolo pubblicato su Mowmag.it, in cui assegna alle Veline “una parte nella storia del sessismo italiano (da Lino Banfi e Striscia la notizia)”. Ci spiace, però, che alla fine sia proprio una donna a essere “sessista” nei confronti di altre donne. Ragazze che, quasi sempre ballerine professioniste, si impegnano ogni giorno in allenamenti, corsi di dizione e recitazione, facendo al meglio il loro lavoro. Certo, sono ballerine professioniste e mentre ballano non possono parlare, ma è un’impresa che non sarebbe riuscita nemmeno a Carla Fracci. Sul peso semiologico della loro presenza ha scritto pagine importanti anche Umberto Eco. Il saggio “Veline e silenzio” è contenuto nella raccolta “L’era della comunicazione”, uscita meno di un anno fa con La Nave di Teseo: una lettura che ci sentiamo di consigliarle.
Ci teniamo a ricordarle che le Veline di Striscia la notizia non sono mai state coinvolte in nessun tipo di scandalo. Quello della Velina è un ruolo. Le Veline di Striscia non usano il metodo Stanislavskij, ma sono più brechtianamente straniate e nella vita reale sono poco gne-gne, etere ed eteree. Le donne oggetto sono da cercare altrove: le consigliamo un ripasso della cinematografia degli anni ‘70. Ma anche solo di sfogliare una qualunque rivista di moda. Già nel 2011, per rispondere a “Il Corpo delle donne” di Lorella Zanardo, la redazione di Striscia realizzò “Il Corpo delle donne 2”, contro-documentario provocatorio che dimostrava l’uso strumentale del corpo delle donne da parte della stampa progressista (soprattutto del Gruppo Espresso) e ne provava la clamorosa ipocrisia. Qui il link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/il-corpo-delle-donne-2_28281.shtml
Inoltre, “Veline” non è affatto un “vezzeggiativo o diminutivo per indicare le ragazze sul bancone”. Per una maggiore comprensione dell’origine e del ruolo delle Veline di Striscia la notizia, riportiamo un passaggio del libro di Antonio Ricci “Striscia la tv” (Einaudi, 1988): «In gergo giornalistico le veline sono quei fogli di carta sottile e semitrasparente che i centri di potere inviavano ai giornali con tutte le indicazioni per tenere l’informazione sotto controllo. Lunghe ricerche etimologiche ci hanno rivelato che le prime veline non erano di carta, ma di carne: “velino” era la pergamena di vitello, nato prematuro. Così a Striscia, sia ben chiaro solo per un fatto culturale, le Veline le abbiamo ripristinate tutte in “vera pelle”, come parodia vivente dei settimanali Espresso e Panorama, che da sempre hanno utilizzato in copertina donne poco vestite o completamente nude. Per un’inchiesta su “La fame nel mondo” mettevano due modelle in costume adamitico che mangiavano una mela e per annunciare la Perestroika una donna nuda col colbacco sulla piazza Rossa. Quello del sesso in copertina è stato il primo gadget venefico, l’allegato mortifero dei settimanali italiani, il primo cedimento franoso nei riguardi della notizia».
Anche in “Me Tapiro” (Mondadori, 2017) il papà di Striscia la notizia, intervistato da Luigi Galella, aggiunge: «Striscia inizialmente durava pochi minuti. I dispacci che le vallette portavano ai conduttori furono chiamati “veline”. E le mani e il corpo che le porgevano divennero tutt’uno con quel nome. Le ragazze erano una sorta di cavallo di Troia, che introduceva la notizia seria dei pensosi commentatori della carta stampata. Il termine aveva più chiavi di lettura: ricordava le istruzioni consegnate ai giornali dal Regime, durante il fascismo, e creava un apparato danzante in un telegiornale, che fosse varietà. C’era la consapevolezza, inoltre, che con queste veline ci incartavano le notizie i più grossi settimanali d’opinione, come Espresso e Panorama. I conduttori le chiamavano proprio Espresso e Panorama, perché le copertine di quei magazine erano piene di ragazze discinte. Basta vedere i settimanali del tempo per rendersene conto (…). Forse tuttora è così. Be’, il termine non nasce certo encomiastico. Quand’ero bambino con le veline ci si incartavano i tarocchi (gli agrumi, non ancora i tarocchi dell’informazione). Decorate con immagini di donne procaci, servivano a proteggere e a non esibire gli eventuali danni alla buccia delle arance, a quei tempi molto delicate. Le veline di Regime danno invece l’idea dell’imposizione e di essere figlie della carta copiativa. Certo, le Veline hanno scatenato polemiche pretestuose… ma a noi, comunque, fa sempre comodo che si aprano i dibattiti».
Cordialmente,
L’ufficio stampa di Striscia la notizia
n.b. l’articolo contestato è questo: https://mowmag.com/attualita/e-se-le-influencer-avessero-una-parte-nella-storia-del-sessismo-italiano-da-lino-banfi-e-striscia-la-notizia

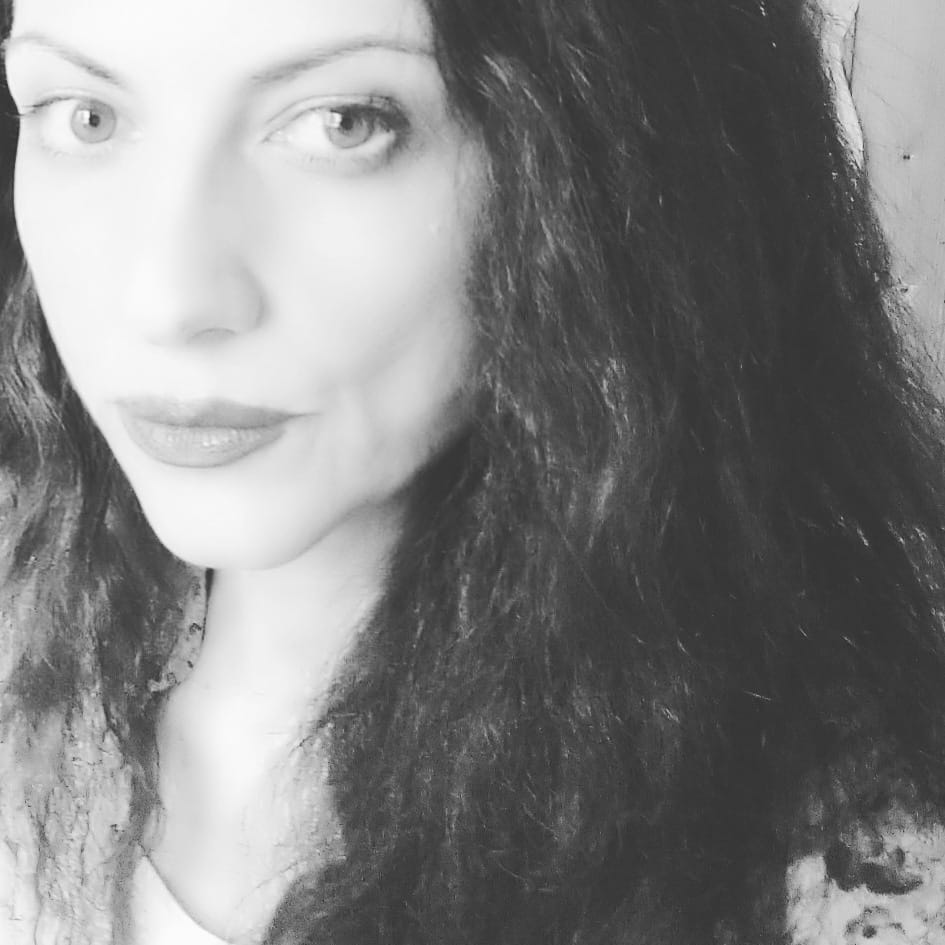

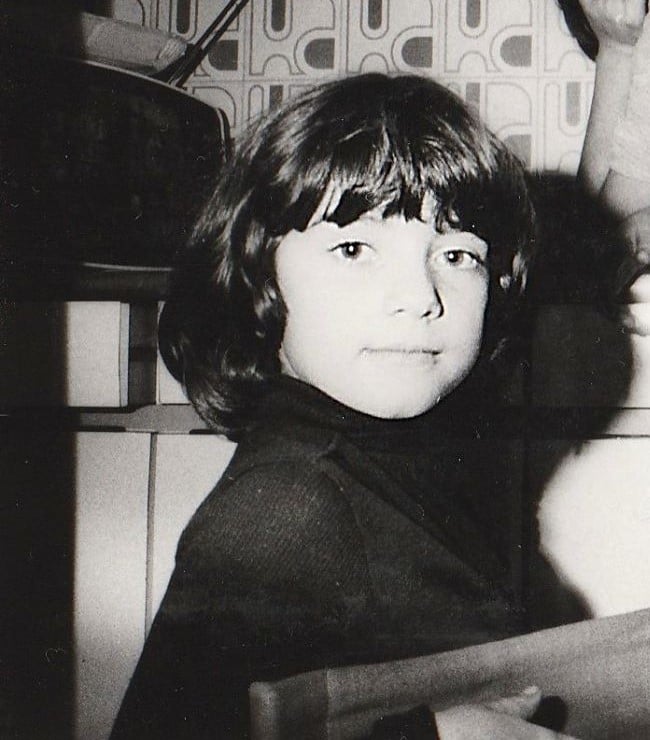








You must be logged in to post a comment.